Quando si parla di mafia, l’immaginario collettivo richiama spesso figure maschili: boss spietati o magistrati impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Sono ruoli di primo piano, fondamentali per comprendere il fenomeno mafioso e le dinamiche che lo caratterizzano. Tuttavia, la mafia non è solo una questione di uomini.
Le donne, spesso relegate a figure di contorno, hanno avuto un ruolo ben più complesso all’interno delle organizzazioni criminali. Madri, mogli, sorelle, da sempre subordinate all’autorità maschile, sono state sia complici – volontarie o inconsapevoli – sia testimoni di realtà difficili, diventando talvolta simbolo di cambiamento.
Tradizionalmente, la cultura mafiosa ha imposto loro una posizione subordinata, escludendole dalle decisioni strategiche dei clan. Tuttavia, il loro compito di educatrici si è rivelato cruciale: a loro spetta il compito di trasmettere i valori dell’organizzazione ai figli. In alcuni casi, hanno assunto ruoli di comando nei traffici illeciti, dalla droga alla prostituzione, e persino preso il posto dei mariti alla guida dei clan, diventando vere e proprie “donne d’onore”.
Non sono mancati casi di donne a capo di mandamenti mafiosi o sottoposte al regime del 41 bis, in particolare nella Camorra, dove la loro presenza è stata più numerosa rispetto ad altre organizzazioni criminali.
Fino agli anni ’90, la giustizia tendeva a minimizzare il loro coinvolgimento attivo nelle attività mafiose, nonostante fosse noto il loro contributo.
Questo ritardo è legato alla complessità del fenomeno e alla visione tradizionale del ruolo femminile all’interno della criminalità organizzata.
Accanto a queste figure, però, esistono anche donne che hanno scelto di opporsi alla mafia.
Collaboratrici di giustizia o testimoni protette che hanno avuto il coraggio di denunciare e di rompere il muro di omertà, pagandone comunque un prezzo elevato: dall’entrare nei programmi di protezione per costruire una nuova vita, spesso insieme ai propri figli, finanche al pagare con la propria vita una scelta di libertà.
Alcune storie in particolare, anche se magari poco conosciute, meritano di essere menzionate.
La storia di Rita Atria, ad esempio, è una delle meno conosciute ma più toccanti nella lotta alla mafia.
Nata in una famiglia mafiosa, perse il padre, Vito Atria, ucciso nel 1985, e il fratello Nicola, assassinato nel 1991. Dopo la denuncia della cognata Piera Aiello, anche Rita decise di collaborare con la giustizia, rompendo con la sua famiglia e con il fidanzato.
A soli 17 anni si affidò al giudice Paolo Borsellino, contribuendo con le sue testimonianze all’arresto di numerosi mafiosi tra Partanna, Sciacca e Marsala.
Costretta a trasferirsi a Roma per sicurezza, la sua speranza crollò il 19 luglio 1992, con l’attentato che uccise Borsellino, figura paterna e guida per lei.
Il 26 luglio, sopraffatta dal dolore e dalla solitudine, si tolse la vita gettandosi dal settimo piano di un palazzo a Roma.
Nel suo diario, Rita lasciò le sue ultime parole, simbolo di una battaglia vissuta non per vendetta, ma per un’idea di giustizia.
Infine, un’altra donna da menzionare e ricordare è sicuramente Letizia Battaglia, una fotografa e fotoreporter palermitana (morta il 13 aprile 2022, all’età di 87 anni) che attraverso i suoi forti scatti in bianco e nero, denunciò coraggiosamente la mafia in più occasioni.



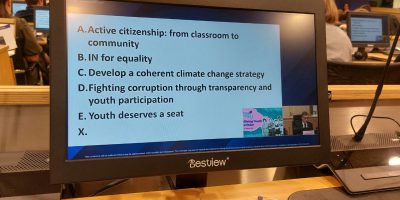





Lascia una risposta